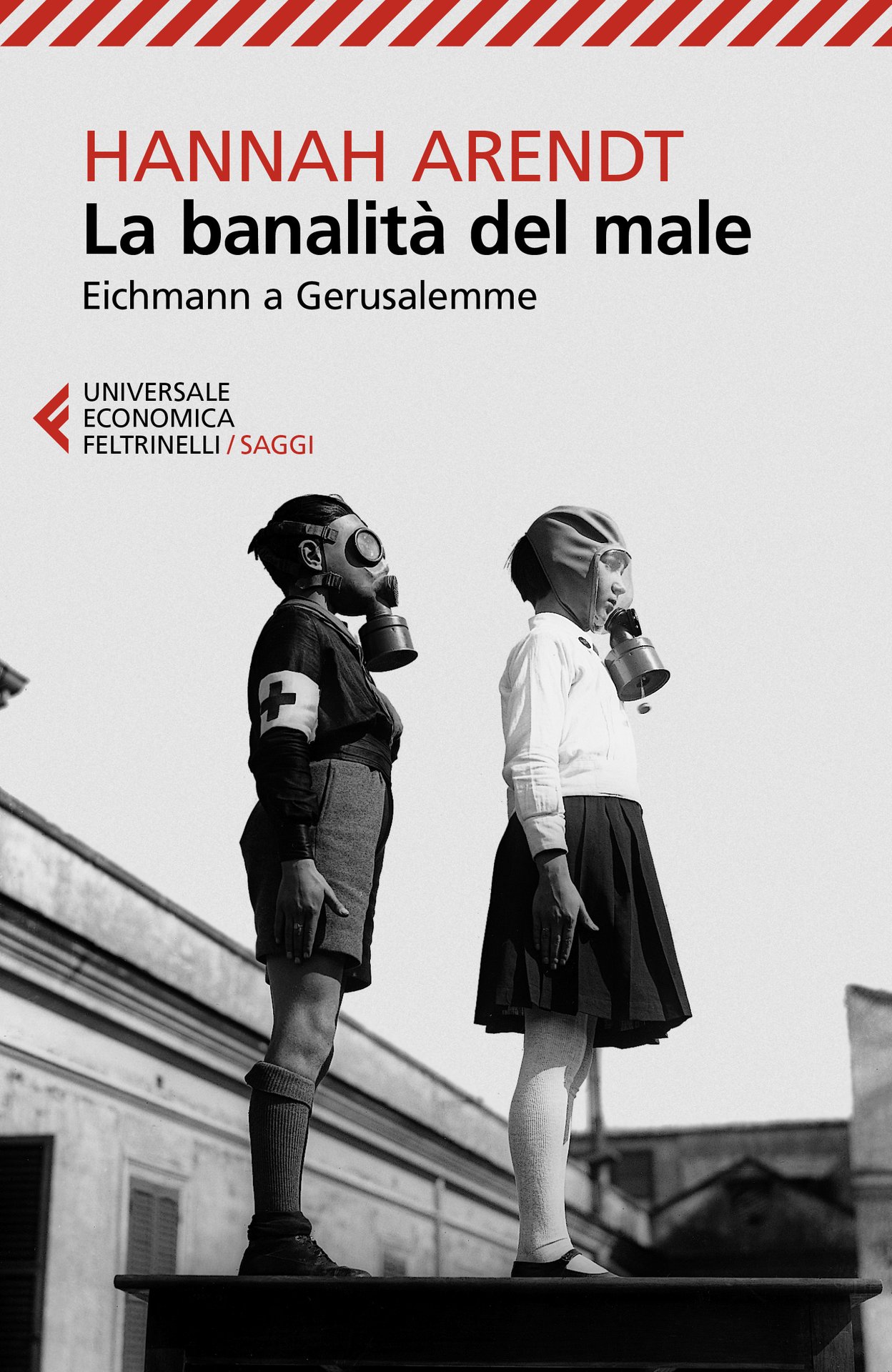
di Silvio Cappelli
SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] ISSN 2281-6569

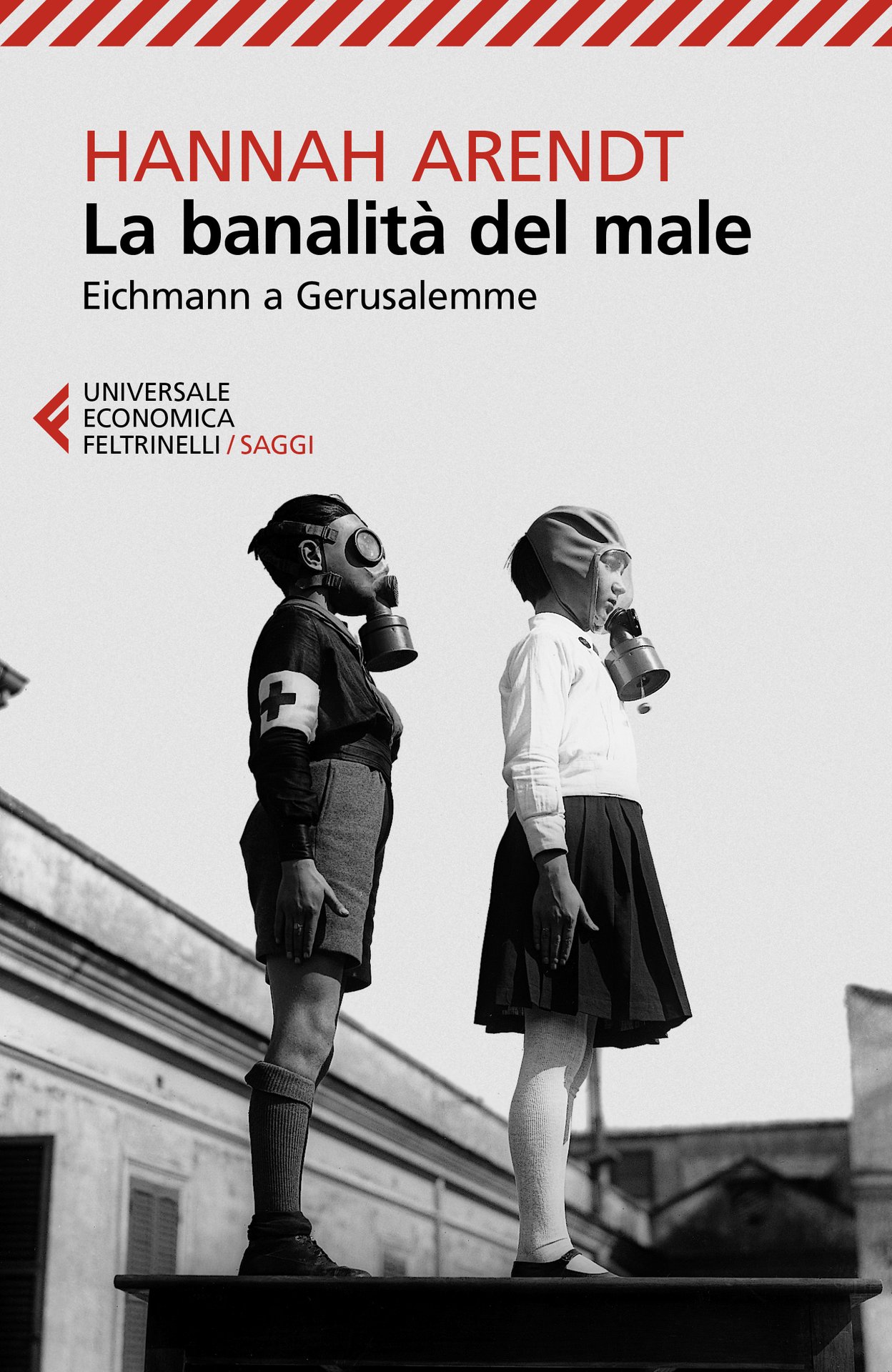
di Silvio Cappelli
SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online] ISSN 2281-6569

di Silvio Cappelli

Il saggio Il futuro del classico di Salvatore Settis si colloca all’interno di una lunga e prestigiosa serie di lavori circa il destino della nostra cultura, dal lontano Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler al più recente Il futuro dell’Occidente di Rémi Brague[1]. Punto di partenza di Settis, in questo saggio del 2004, è la constatazione, semplice e scontata, dell’odierno sbandieramento del classico come luogo di origine della nostra cultura a cui però non fa seguito, o non corrisponde, una vera e propria conoscenza e sensibilità classica. A partire dalle riforme della scuola a cavallo del nuovo secolo fino all’ignoranza ormai riconosciuta ed ammessa delle lingue antiche, la nostra società vive in uno stato di “cattiva coscienza”, per dirla con Hegel. Una tale situazione, secondo Settis, cela dietro di sé un forte disorientamento dovuto alla grave mancanza di un orizzonte autentico verso cui dirigersi. Disorientamento verso il futuro, appunto, che genera per contraccolpo il ripiegamento coatto e acritico verso un passato inteso come Sancta Sanctorum dell’identità occidentale. Solo che questo ritorno al passato è un puro “smalto sul nulla”, a cui è possibile porre rimedio solo se si guarda al classico in modo diverso. Vale a dire, il passato deve essere inteso non più come luogo dell’identità, bensì come spazio di sintesi contrastante, di identità e di differenza insieme. L’identità, tanto sbandierata ma spesso incompresa, passa perciò attraverso il riconoscimento dell’altro, dove per “l’altro” si intendono le altre culture, le altre civiltà, il diverso da noi. Non più dunque identità fissa e rigida, imbalsamata, e a cui bisogna genuflettersi in venerato rispetto, bensì identità aperta, attraversata dai rivoli della diversità.
Notevole è perciò il riferimento di Settis all’antropologo e storico delle idee, Aby Warburg, fondatore dell’omonimo istituto, grande protagonista della cultura tedesca ed europea della prima metà del XX secolo, ed autore di scritti fondamenti della storia dell’arte, tra cui il celeberrimo La Rinascita del paganesimo antico[2]. In questo testo, che mette insieme diversi saggi scritti tra il 1917 e il 1922, Warbug ci mostra, secondo Settis, come debba intendersi “il classico” in modo autentico, soprattutto nel porre la questione centrale della “rinascita” in un contesto spazio-temporale totalmente diverso come quello del XV secolo. Ciò che assicura una percezione autentica del classico è, secondo Warburg, la persistenza di Pathosformeln, cioè di formule espressive, che riaffiorano nel corso della storia e che nel XV secolo permisero agli artisti di intuire quei motivi caratteristici dell’antichità.
L’esempio delle Pathosformeln di Warburg è dunque uno dei migliori esempi di come, secondo Settis, lo sguardo al passato possa avvenire nella piena consapevolezza della propria alterità da esso eppur tuttavia nell’identità della forma.
[1] S. Settis, Futuro del classico, Einaudi, Torino 2004. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale, Longanesi, Milano 1981. Rémi Brague, Il futuro dell’Occidente. Nel modello romano la salvezza dell’Europa, Bompiani, Milano 2016. Circa le problematiche e il dibattito sul tramonto dell’Occidente mi permetto di rinviare al mio saggio, Agonia e ripristino della civiltà. Albert Schweitzer interprete di Paolo, pp. 77-100,in Paolo di Tarso. Testimone del Vangelo “fuori le mura”, a cura di Claudio Monge, Nerbini Editore, Firenze 2009.
[2] Aby Warburg, La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla storia della cultura, La Nuova Italia, Firenze 1966.
di Mara Gentile
SFI Sezione di Sulmona Giuseppe Capograssi [online]
ISSN 2281-6569 agosto 2023